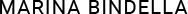Claudio Zambianchi Ciampini strazza-bindella 2006
Radici del segno
Uno degli aspetti più emozionanti delle riflessioni sul segno di Guido Strazza sta, a mio vedere, nel considerare la lastra e il foglio come un microcosmo vitale che fa da specchio – secondo modalità complesse e niente affatto ovvie – al nostro vivere ed esperire il mondo. Strazza – a me pare – riporta alla fenomenologia del vedere la famosa metafora di Paul Klee secondo la quale l’artista è come il fusto di un albero le cui radici affondano nel terreno e le cui fronde si aprono nell’aria. Tra le radici (l’esperienza del mondo) e le fronde (le opere) non vi è una corrispondenza formale esatta; e tuttavia il vigore delle seconde dipende dal buon funzionamento delle prime, con la mediazione, fondamentale, del tronco, che filtra, fluidifica e trasforma la linfa del terreno in nutrimento per le foglie. Se si applica una metafora siffatta al segno, così com’è interpretato da Strazza, ci si rende conto che, a differenza di Klee, le radici della sua arte non pescano in un mondo sotterraneo di simboli nascosti, né si pongono in analogia diretta con i fenomeni della natura. Il segno è piuttosto la metamorfosi grafica di un aspetto dell’esperienza al fine di chiarirla: anche Strazza dunque, come Klee, non vuole riprodurre il visibile, ma rendere visibile. Quel che è reso visibile è tuttavia l’esperienza in atto, i momenti – sempre provvisori – che consentono di incontrare il mondo, di dar conto del nostro esistere in esso. L’azione del vedere definisce un incontro fra due fattori inseparabili agli occhi di Strazza: la soggettività e l’oggettività. Senza un’unione siffatta il mondo, per noi, non esisterebbe. Torna alla mente, leggendo i testi di Strazza, il Merleau-Ponty della Fenomenologia della percezione, e soprattutto, di quello straordinario testo, la nozione di una modalità del vedere continuamente in movimento: l’essere umano non può sottrarsi a un continuo slancio verso quel mondo che, nell’atto del vedere, rende presente alla coscienza. Il segno è capace di attuare momento per momento sintesi di questo rapporto sempre mobile e inesauribile. Un siffatto carattere dinamico contraddistingue sin dagli inizi il lavoro di Strazza, visti anche i giovanili rapporti dell’artista con Filippo Tommaso Marinetti; ma alla radice futurista si mescola ben presto la relazione con l’arte degli americani dell’Espressionismo astratto. Un concetto come quello espresso da Pollock verso il 1950 quando diceva di concepire il suo lavoro come “energia e movimento resi visibili”, sembra importante per Strazza, a condizione tuttavia di mettere in parentesi la radice surrealista di una siffatta modalità di concepire il segno. A Strazza non interessa far affiorare l’inconscio attraverso procedimenti automatici: l’intento non è quello di proporre all’analisi un materiale in statu nascenti, ma di far decantare una tale sostanza al fine di presentarla, a se stesso e agli altri, già a un certo stadio di chiarimento, nel momento cioè in cui l’energia si è coagulata, si è tramutata in forma: in cui i valori di movimento e di temporalità siano non soltanto proposti, ma anche, almeno in parte, resi limpidi e leggibili. Meno romantico e più consapevole della generazione che lo ha preceduto, Strazza non sembra persuaso di un’utopistica originarietà del segno, ma vede quest’ultimo, anche nelle sue manifestazioni più elementari, come parte di un linguaggio, strumento di comunicazione: questo, almeno, a me sembra il senso della frase: “Identificarsi con il mondo non vuol dire perdersi nel mondo, vuol dire esserci; per esserci senza perdersi bisogna tracciarsi un sentiero, ‘riconoscerlo’, avergli dato un nome”. Sotto questo aspetto, può essere utile una riflessione: si usa dire che il disegno è più mentale, mentre il colore aderisce più immediatamente alle modalità del nostro vedere: se da certi punti di vista questo è vero, da altri, come fa notare Peter Galassi nel suo libro su Corot in Italia, la lunga storia delle convenzioni artistiche fa sì che basti una traccia di inchiostro o di grafite su un foglio di carta perché quest’ultimo si trasformi in un campo animato da una presenza (oggetto, figura, paesaggio, punto, linea, poco importa): l’interazione tra il segno e il bianco della carta significa, immediatamente. Una pennellata di colore, per assolvere alla stessa funzione significante, chiede più spesso il rapporto con altre parti campite; in assenza di una relazione siffatta la superficie bianca della tela resta ferma, tende a essere mero supporto.
Nel pensiero di Strazza, la superficie è un campo perché la sua inerzia è immediatamente annullata dalla qualità dinamica del segno. Quest’ultimo è sempre determinato da un gesto, e anzi chiarisce quel gesto; lo rende, in senso proprio, leggibile: “I segni – dice l’artista – sono prima di tutto tracce di gesti. Come tali prima che forme sono apparizioni, qualcosa che cresce, è cresciuto e potrebbe crescere ancora sotto i nostri occhi”. Riportare l’esperienza al segno e riportare il segno all’esperienza: questa, a me sembra, la funzione della grafica presso Strazza. L’aspetto straordinario di questa produzione sta più nella limpidezza con cui è distillato il rapporto fra i due termini della relazione che non nella eccezionalità dell’esperienza. In altri termini, il mondo proposto dai fogli di Strazza non affonda, lo si è già detto, negli umori misteriosi della terra o del profondo individuale. A me sembra piuttosto un mondo di esperienza condivisa, kantianamente trascendentale, dove la riflessione è portata il più delle volte su aspetti riconducibili al senso comune e alle associazioni immediate che ad esso si accompagnano: rapporti tra sopra e sotto, tra verticali e orizzontali, tra addensamenti e rarefazioni, tra ordine e disordine. Nel mondo di Strazza alcuni dati di partenza esistono già, perché sono parte del patrimonio comune. Il fine del lavoro sta nel porsi in consonanza con loro, lavorare in accordo o in disaccordo con essi, tenere o lasciare, sottolineare o contraddire le associazioni abituali che vanno, storicamente, col segno. Ne risulta una inesauribile plasticità che consente al segno di Guido Strazza quegli incontri tra le immagini e la realtà visiva del mondo esterno che tanto hanno colpito critici quali, per esempio, Roberto Tassi: “Il pittore – scrive Tassi – ha una vista tanto acuta da poter leggere, capire e assimilare i segni che sono sparsi ovunque […], nella natura, nelle opere dell’uomo, nell’uomo stesso, nell’azione del tempo, i ‘geroglifici egiziani’ della realtà”. La condizione è tuttavia quella di ammettere che i riscontri fra le immagini e il mondo non vengano interpretati alla luce del bisogno di rappresentare la realtà fenomenica: presso Strazza la creazione appare come una forma di chiarimento del proprio vedere, un darsi ragione del proprio agire e del proprio pensare attraverso un fare, una operatività precisa. Particolarmente nell’incisione, dove la fluidità del segno, la sua risposta all’azione della mano o del corpo non sono immediate, ma filtrate da una materia la cui resistenza va forzata o scavando direttamente o avvalendosi dell’azione dell’acido. In una zona siffatta si definisce con maggior esattezza la “divergenza sottile” (così bene individuata da Guido Giuffrè) fra il “qui e ora dell’artista, [il] gesto in procinto di farsi immagine” e “il segno, trasfuso già nella dimensione dell’immagine”.
Alcune delle idee esposte sopra si applicano al lavoro di Marina Bindella, artista più giovane di Strazza di quasi due generazioni, e già da molti anni in viaggio sul cammino dell’incisione. Il mondo formale di Bindella è tuttavia diverso da quello di Strazza. L’artista lavora infatti su morfologie che, nel loro manifestarsi, evocano più scopertamente di quanto avviene in Strazza episodi della vita organica quali battiti, pulsazioni, addensamenti, distensioni. Questo perché alle tecniche calcografiche predilette da Guido Strazza Marina preferisce quelle xilografiche, rivolte alla creazione di unità piccole, talora pulviscolari, sulla cui trama si dispongono a volte segni più liberi, ottenuti tuttavia non per via di una traduzione diretta del gesto, ma “per via di torre”, scavando la lastra attorno ai segni e non incidendoli direttamente sulla matrice; la decisione del segno appare quindi il risultato non già di un impulso, ma di un’analisi decantata della qualità del suo tracciato, frutto di un differimento della gestualità immediata. A tale riguardo può venire utile un paragone con il mosaico, similitudine che non mi sembra impropria vista la concentrazione di segni di Marina sugli effetti di luce: è come se Bindella creasse prima tessere di formato e dimensione diversi, e poi le disponesse sul foglio secondo una idea compositiva strutturata e coerente. Questo le consente di accordare la disciplina della tecnica, perseguita con dedizione profonda, alle necessità dell’espressione immediata, caratteristica invece dell’artista moderno: il segno cioè chiarisce e distilla un modo di sentire, definisce una modalità di passaggio tra uno stato della mente e la forma che, di volta in volta, gli si adegua. Il controllo che il mezzo incisorio, per poter parlare, porta con sé serve a chiarire e a trasmettere con maggior precisione un dato emotivo.
Al di là delle pur significative differenze, tuttavia, Bindella mi sembra condividere con Strazza l’idea del segno come risposta a una esigenza di chiarimento che si manifesta nell’atto di operare. La propensione allo studio specifico del segno costituisce il carattere emergente del lavoro di Marina: malgrado l’ormai pienamente acquisita libertà dell’artista moderno rispetto a quello del passato, nonostante opzioni tecniche che si sono fatte col tempo sempre più soggettive, alcuni domìni – e specialmente quello dell’incisione – restano appannaggio di chi padroneggia a perfezione le tecniche. Come un musicista non può comporre se non conosce le leggi della musica, così un incisore non può aspirare a raggiungere un qualche risultato se non è pienamente padrone dei suoi mezzi. Può inventare segni nuovi, comporre nuovi alfabeti, ma a un certo punto, perché queste acquisizioni si traducano in risultati visibili, bisogna che si strutturino in una grammatica. Benché Marina lavori anche con il disegno e con l’acquerello, a mio vedere è l’incisione che ha nel suo lavoro una funzione generativa: le tecniche incisorie sono il luogo dove gli alfabeti vengono inventati, e messi a punto; le lettere che li compongono legate a formare parole; le parole congiunte a formare frasi; le frasi riunite e subordinate le une alle altre secondo un principio sintattico. Si tratta di un esercizio quotidiano e disciplinato che va alla ricerca di una solidarietà tra un’idea poetica soggettiva e un segno variabile, duttile, capace di volta in volta di risolverla in immagine. La perizia tecnica è mossa dalla passione e dall’emozione; caratteri che nei lavori degli ultimi anni di Marina si sono fatti più scoperti, di pari passo con l’accentuarsi della presenza dei ricordi del mondo organico, in immagini che tuttavia mai arrivano a lambire la referenzialità diretta. Anche le opere grafiche di Marina, come quelle di Strazza, trovano quindi affinità con le immagini proposte dal mondo esterno, ma cambia – a me pare – la natura dell’incontro: se in Strazza esso è parte di un processo conoscitivo basato sull’agire, sul gesto, in Marina è determinante il ruolo della memoria: le forme che da un quindicennio a questa parte Marina propone non offrono una copia del mondo esterno; sono piuttosto il frutto di un processo inventivo che sembra risolversi laddove l’immagine, nella sua qualità luminosa, trova un momento di coincidenza con un suggerimento della memoria: in altri termini, è il configurarsi dei segni che muove il ricordo, non viceversa.
Nelle intenzioni dei due autori, le opere esposte in questa mostra vogliono porre una domanda: “Che senso ha fare incisione oggi?”. Provando a rispondere all’interrogativo a conclusione delle riflessioni svolte, a me sembra che il senso del lavoro proposto da Guido Strazza e Marina Bindella sia il seguente: il segno è un fattore di consapevolezza, dell’operare e del proprio stare nel mondo; aiuta a dare un senso alle intermittenze del nostro sentire, a illimpidire momento per momento le incertezze del nostro percepire; in questo chiarimento, sempre provvisorio e sempre indispensabile, sembra risiedere, presso Guido e Marina, la funzione illuminante del segno stesso, oggi.
Claudio Zambianchi